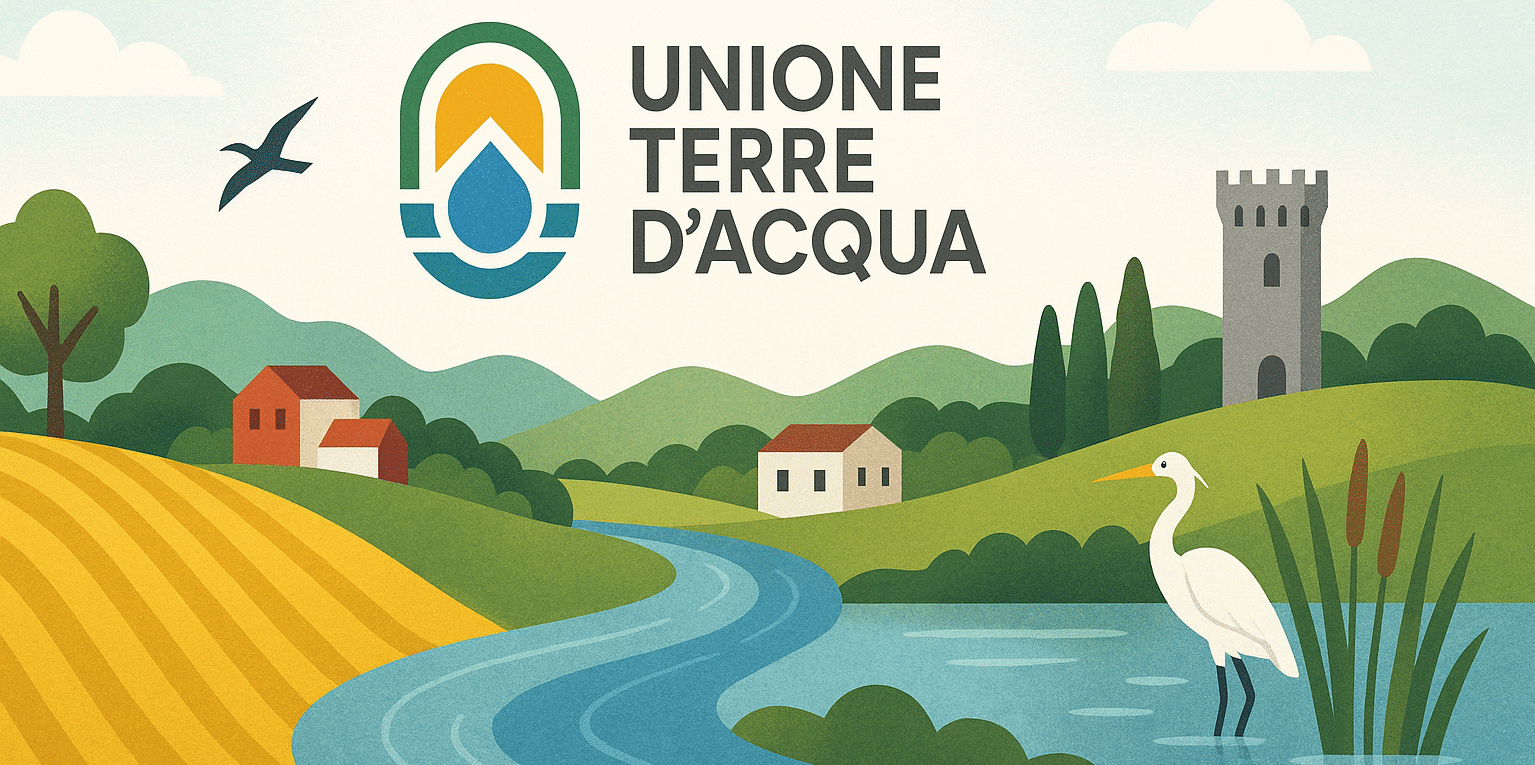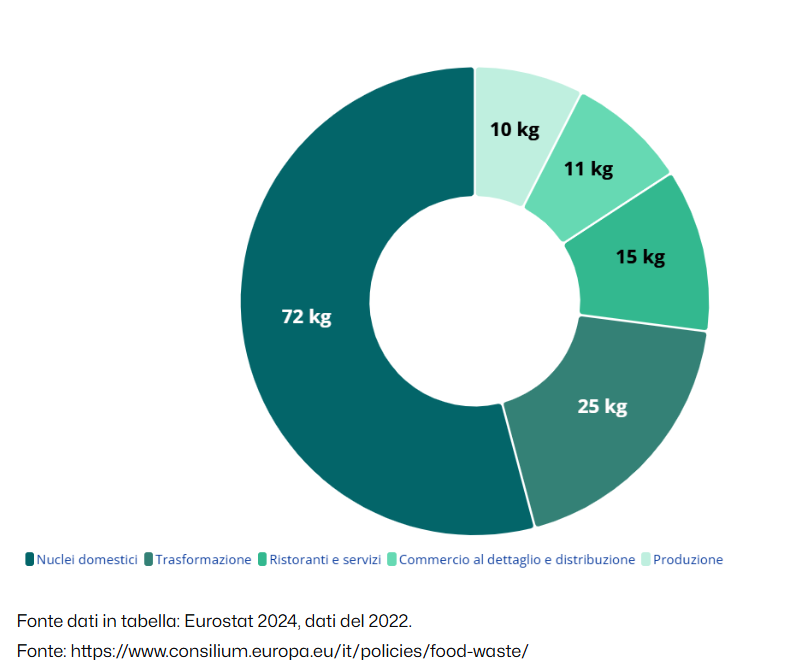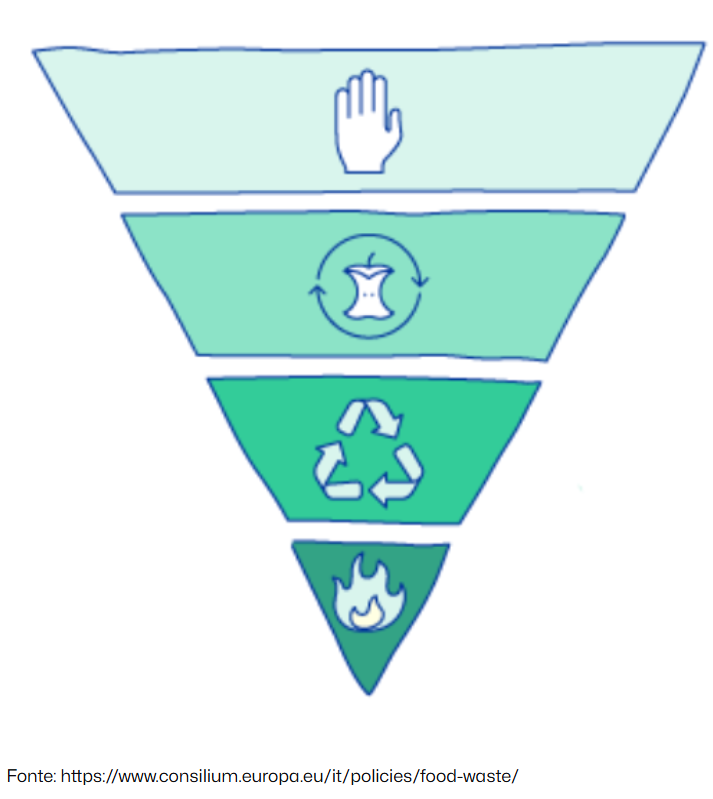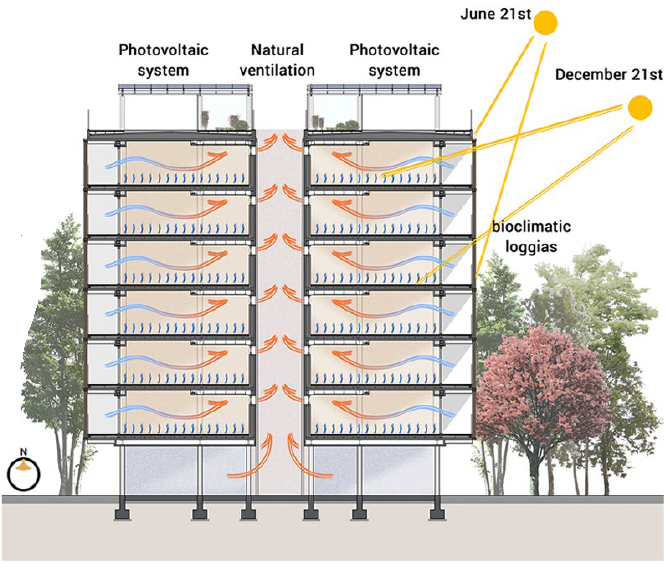Un’iniziativa recentemente attivata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy mette a disposizione oltre 178 milioni di euro per sostenere le piccole e medie imprese italiane che intendono investire in impianti per la produzione autonoma di energia da fonti pulite. L’intervento finanzia installazioni fotovoltaiche, soluzioni mini-eoliche e sistemi di accumulo energetico, contribuendo alla riduzione dei costi e al raggiungimento degli obiettivi ambientali nazionali.
L’incentivo, regolato da una procedura a graduatoria, si inserisce all’interno del piano REPowerEU del PNRR (Investimento 16) e rappresenta una concreta leva per rafforzare la resilienza e la competitività del tessuto produttivo nazionale, supportando al contempo la transizione energetica.
Dotazione finanziaria e finalità
La misura dispone di una disponibilità iniziale pari a circa 178,6 milioni di euro, provenienti dalle risorse residue del precedente sportello attivato nel marzo 2025. Tali fondi potranno essere incrementati in caso di rinunce o esclusioni durante l’iter di valutazione. L’obiettivo è incentivare le PMI a dotarsi di impianti rinnovabili destinati all’autoconsumo, anche attraverso l’integrazione di sistemi di accumulo per un utilizzo differito dell’energia prodotta.
Accesso e valutazione dei progetti
Le modalità operative seguono quanto già definito nel decreto ministeriale del 14 marzo 2025. I progetti candidati saranno sottoposti a valutazione sulla base di parametri tecnici e oggettivi, quali efficienza, innovazione tecnologica, solidità economico-finanziaria e impatto ambientale. Ogni azienda potrà presentare una sola proposta progettuale. In caso di più invii, sarà considerata unicamente la versione più recente.
Requisiti e limitazioni
L’accesso all’agevolazione è riservato alle PMI che soddisfano i requisiti stabiliti nei provvedimenti precedenti (13 novembre 2024 e 14 marzo 2025). Sono esclusi dal beneficio i settori indicati nell’Allegato 1 del decreto – tra cui agricoltura, estrazione mineraria, produzione di tabacco, lavorazione del petrolio, gioco d’azzardo – nonché le imprese a elevata intensità energetica iscritte negli elenchi CSEA e quelle con elevate emissioni in ambito ETS. Le aziende operanti nella mobilità possono accedere solo se almeno metà del fatturato deriva da veicoli a zero emissioni. Non sono inoltre ammessi soggetti già beneficiari del primo sportello.
Tempistiche e invio delle domande
Le richieste devono essere presentate esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma Invitalia (www.invitalia.it), a partire dalle ore 12:00 dell’8 luglio 2025 e fino al termine ultimo del 30 settembre 2025, ore 12:00. Sarà necessario allegare una serie di documenti tra cui:
- relazione tecnica asseverata;
- dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti;
- documentazione economica e finanziaria dell’impresa;
- eventuali certificazioni ambientali o sulla parità di genere.
Valutazione e obblighi dei beneficiari
L’istruttoria sarà condotta da Invitalia sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di riferimento, tenendo conto di fattori quali l’impatto ambientale, la sostenibilità tecnica del progetto e la capacità dell’impresa di realizzare gli interventi. Le imprese ammesse saranno tenute al rispetto di obblighi specifici, tra cui:
- adozione del principio “Do No Significant Harm” (DNSH);
- divieto di cumulo con altri finanziamenti pubblici;
- obbligo di tracciabilità contabile delle spese;
- disponibilità a ispezioni e controlli da parte degli enti competenti.