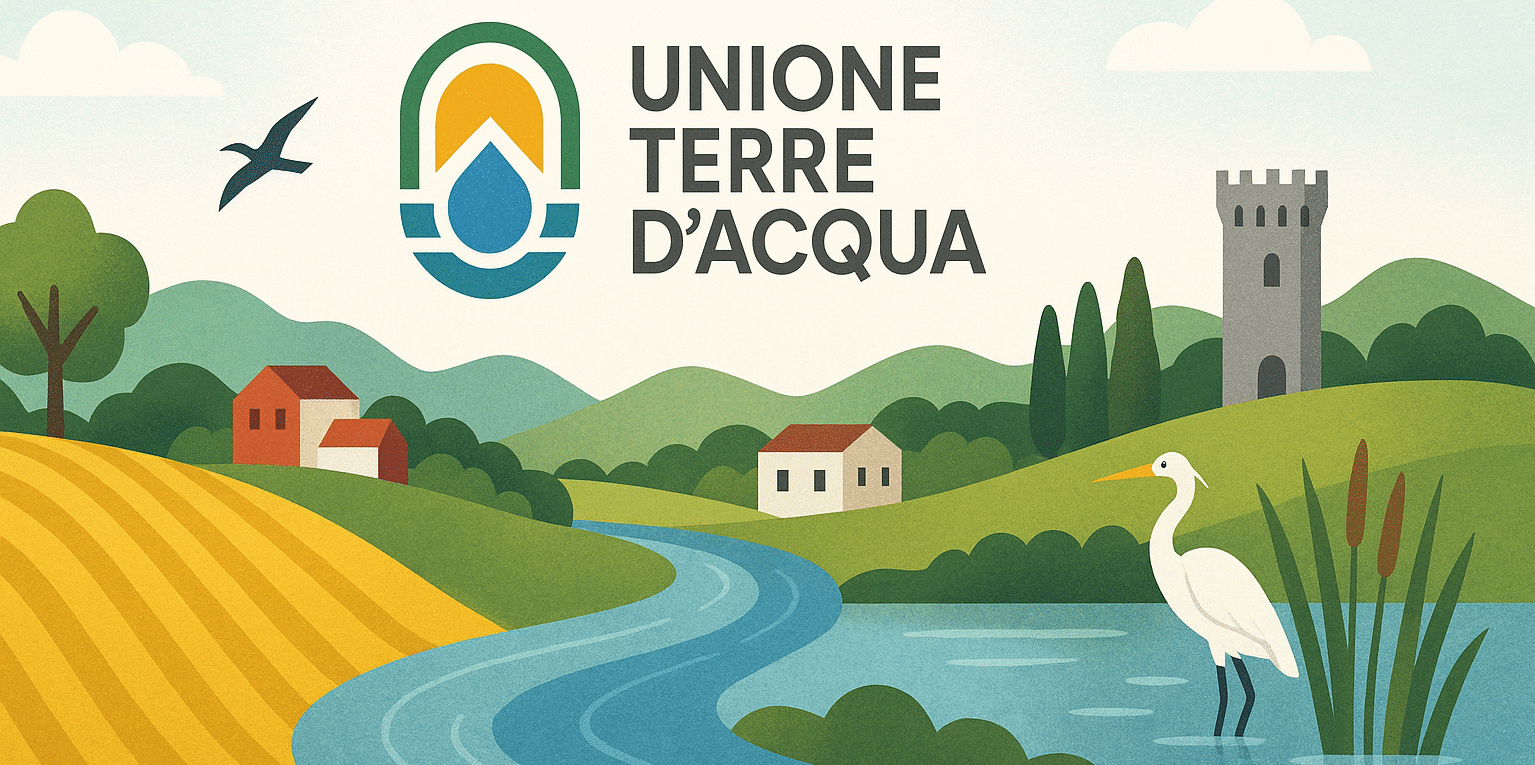Negli ultimi anni gli edifici nZEB (nearly Zero Energy Building) sono diventati il simbolo dell’efficienza energetica europea. Ma dietro l’apparente universalità del concetto si nasconde un equivoco tecnico: il modello nasce in Nord Europa, dove l’obiettivo è trattenere il calore in climi freddi. Applicato agli stati del sud Europa, questo paradigma mostra i suoi limiti in buona parte dei territori di questi stati: il problema potrebbe essere (in prospettiva) non tanto scaldare, quanto raffrescare o perlomeno cercare un migliore assetto tra le due esigenze.
Nei paesi che si affacciano sul Mediterraneo servono edifici capaci di smaltire il calore, non solo di isolarlo. L’efficienza, qui, significa ombra, ventilazione e inerzia termica in periodi lunghi dell’anno più che tenuta all’aria e spessori isolanti.
Lezioni dal passato e nuove strategie
L’architettura tradizionale mediterranea ci offre soluzioni già collaudate: muri spessi, cortili interni, logge e superfici chiare che riflettono la radiazione solare. Oggi questi principi vengono reinterpretati con materiali e tecnologie moderne, come schermature mobili, ventilazione notturna e tetti verdi.
Studi ENEA mostrano che un buon controllo solare può ridurre del 40% i carichi estivi, mentre la ventilazione naturale abbinata a materiali ad alta massa termica può smorzare i picchi di temperatura del 50%. Anche il fotovoltaico trova qui il suo ambiente ideale: in Italia un impianto da 5 kWp può produrre da 5.000 kWh fino a 7 000 kWh l’anno.
Oltre la norma: verso un modello climatico-adattivo
Le direttive europee sull’efficienza energetica riconoscono la diversità dei contesti, ma i metodi di calcolo restano spesso “limitati”, basati su modelli statici che non riflettono il comportamento reale di un edificio mediterraneo. Serve un approccio che valorizzi il comfort adattivo e le strategie passive, misurando non solo il consumo ma anche la qualità ambientale.